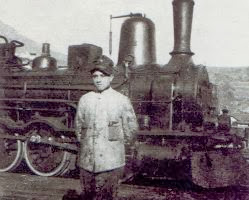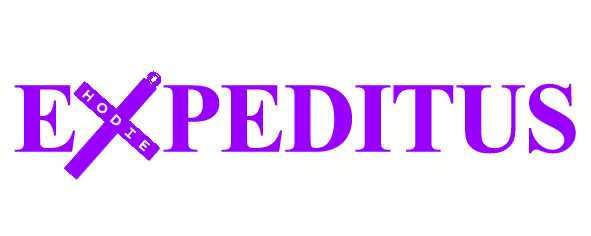C’è chi ha affermato che Espedito non fosse un vero nome, ma soltanto un aggettivo, come se ciò provasse che il nostro santo non è mai esistito. Questa arbitraria tesi si può smontare in vari modi, come già fatto nel mio libro, a partire proprio dal fatto che tale nominativo era comune nel mondo latino, e archiviare così l’argomento.
Eppure, anche da un’affermazione banale o casuale, può prendere avvio una ricerca che conduce a scoperte interessanti; come in questo caso. Studiando infatti la diffusione del nome Espedito nell’Italia del ‘900, soprattutto al Sud, appare quanto spesso si accompagni a onorevoli e talvolta eroiche vicende di giovani, militari e civili, in circostanze belliche: quando deve emergere il coraggio e l’altruismo, a costo della propria vita.
È questo il caso di Espedito Neve, nativo della cittadina di Castelforte (Latina), da povera famiglia; la madre dopo la prematura morte del marito, si trasferì dalla sorella a Galluccio (Caserta). Appena diciannovenne, ma già ricercato dai tedeschi per il suo atteggiamento ribelle ed il carattere indomito, Espedito non ebbe timore a consegnarsi per evitare ritorsioni contro la famiglia, e nell’ottobre 1943 fu internato nel campo di concentramento di Gersthofen, in Bavaria. I prigionieri erano colà usati per lavori forzati: tenuti in un recinto con al centro una grande baracca in legno, divisa in camerate, ci si alzava alle cinque per andare a lavorare dodici ore al giorno.
Ciò che accadde una gelida notte di quell’inverno, lo raccontò anni dopo la moglie Filomena Di Lorenzo: «Le due sentinelle di guardia serrarono come ogni sera le porte delle camerate occupate dai prigionieri, chiusero il cancello del recinto e andarono a divertirsi nel vicino paese. Una fiamma si sviluppò poco dopo nella loro camera, attaccando il letto ricoperto da tavole di legno e carta incatramata, e le fiamme alimentate dal vento ben presto si dilagarono in tutta la baracca adiacente.»
Uno dei prigionieri del campo, Anselmo Mazzi, pubblicò a sua volta un resoconto (“Prigioniero n. 8744”) di quei momenti drammatici: «In un istante tutti eravamo fuori della cuccia; alcuni si precipitarono alla porta cercando di forzare la serratura o addirittura rompere con i panchetti la porta, ma questa resisté ai colpi furibondi dei più forti. Le finestre poi erano munite di una robusta inferiata. Intanto il fuoco ed il fumo, con il cattivo odore di catrame, aumentava in modo impressionante, io non potevo più respirare; dall’asfissia stavo per cadere a terra; la disperazione si impadroniva di ognuno. Le urla disperate, il terrore per la terribile morte che stava per afferrarci, ci faceva impazzire. Più d’uno era in preda al delirio e piangeva.»
Espedito riuscì a trovare uno strumento da lavoro e, sostenuto da un altro detenuto di Treviso, senza perdere la calma, prese a colpire con sovrumana energia la porta della baracca, che alla fine cedette. Tutti riuscirono a salvarsi, più di 200 persone.
Liberato, e rientrato a Galluccio nel giugno 1945, condusse una vita di onesto lavoro; si sposò, ebbe quattro figlie e tanti nipoti, circondato dall’affetto dei quali si spense nel 2002.
Ma nonostante la sua modestia, l’eco dell’atto eroico non si era spenta, e due anni dopo la sua scomparsa una delegazione dalla Germania arrivò a Galluccio per onorarlo e fu così che la cittadinanza scoprì l’eroismo del suo concittadino.
Analogo nell’abnegazione, ma diverso nell’esito, fu l’episodio che vide coinvolto Espedito Senatore, capotreno e protagonista nella tragedia ferroviaria maggiore d’Italia: quella della notte tra il 2 e il 3 marzo 1944, a Balvano (Potenza).
Sul tragico fatto, dove perirono circa 600 persone, è stato scritto un esauriente libro-inchiesta, da parte di un avvocato di Roma, Gianluca Barneschi , dal quale sono tratte le informazioni più attendibili riguardo al nostro eroe, qui riportate.
«Un vero mito locale, figura emblematica di un mondo che non esiste più, Espedito Senatore era cresciuto con la passione per la ferrovia: a diciotto anni (allora minore età) per essere assunto dovette ottenere nullaosta firmato dal padre.
Nei successivi vent’anni, divenne uno dei macchinisti di punta del deposito di Salerno. Le foto che lo ritraggono vicino ai “suoi” rotabili sono emblematiche: il giovane Espedito non appare in grado di mantenere pose rigorose, l’espressione è sempre beata.
Espedito Senatore, nel 1944, era un uomo felice: aveva una bella famiglia (moglie e tre figli), era conosciuto e rispettato nella sua comunità e tra i suoi colleghi. Soprattutto cercava sempre di essere positivo e generoso: alcuni testimoni ci hanno raccontato che Espedito s’intrometteva sempre quando le forze dell’ordine cercavano di sequestrare ai passeggeri (più o meno regolari) dei suoi treni i generi alimentari, faticosamente acquisiti.»
In una gelida notte piovosa, nella tratta Battipaglia-Potenza, zona già controllata dagli Alleati, il treno a carbone 8017 alla guida di Espedito, stracarico di militari e civili sfollati, molti dei quali saliti di straforo, giunto a metà di una stretta galleria lunga quasi un chilometro, non riuscì a superare la modesta pendenza e si arrestò del tutto. Resosi conto del pericolo mortale rappresentato dal monossido di carbonio emesso dalla caldaia, il macchinista Espedito tentò l’estrema manovra di innestare la retromarcia, ma colpito dai gas venefici si accasciò sul posto di guida, dove fu poi trovato.
«Ma prima di chiudere gli occhi per sempre, egli compì un gesto eroico e riuscì a salvare una vita umana. Mentre tentava disperate manovre, fece mettere il suo fuochista, Luigi Ronga, sul predellino e, dopo un po’ lo spinse giù dalla locomotiva. Questo gesto salvò la vita di Ronga, che cadde nella cunetta di scolo dell’acqua, a fianco del binario e, pur perdendo i sensi, il poco d’ossigeno sprigionato dall’acqua bastò a mantenerlo in vita.»
Il palleggiamento di responsabilità tra i diversi comandi militari, le autorità amministrative e operative, portarono di fatto al progressivo accantonamento dell’inchiesta e infine della memoria stessa della tragedia.
Tuttavia ̶ come testimonia ancora Barneschi ̶ «L’insegnamento e lo statuto ontologico di Espedito sono ancora testimoniati dai suoi figli, che, nonostante la tragedia e la successiva indifferenza di uomini e istituzioni, conservano decoro e compostezza ammirevoli.»
Tra i valorosi combattenti periti nell’esperimento del dovere, troviamo invece il poliziotto Espedito Principe, di 35 anni, caduto in Montenegro per impedire ai guerriglieri cetnici di conquistare una posizione che avrebbe messo a rischio altri commilitoni; e il sergente Espedito Colizzi, “Croce al valor militare”, di 23 anni, barbaramente trucidato mentre, nel caos seguito all’Armistizio, con un gruppo di dieci compagni cercava di riposizionarsi nelle zone controllate dagli Alleati.
L’unico valore dimostrativo di questi fatti è la diffusione del nome comune?
Non lo credo. Certo i genitori che diedero il nome Espedito ai propri figli vollero che il giovane martire romano fosse il loro patrono e modello di coraggio. E posso immaginare che nel momento in cui ognuno di loro affrontò l’estremo pericolo, abbiano pregato il santo di infondere loro la forza di accettare una morte eroica.